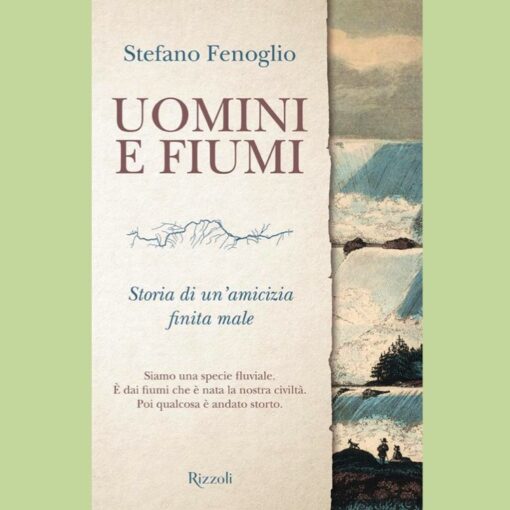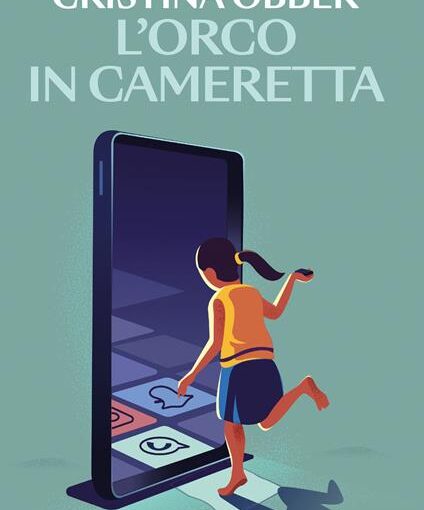Agosto è un mese decisamente generoso con chi decide di trascorrere le vacanze in montagna: durante le escursioni potranno godere di merende a base di Mirtilli e Lamponi. Le More, invece, saranno alla portata di tutti: basterà percorrere un qualsiasi stradello di campagna per poterne fare delle scorpacciate. Stando attenti a non macchiarsi, però!
Ma guardiamo un po’ da vicino queste meravigliose dispensatrici di dolci esperienze.
In comune hanno la “taglia”: sono piante perenni legnose con gemme svernanti che possono assumere anche dimensioni notevoli.

Il Mirtillo (Vaccinium myrtillus) è un’Ericacea; ha fusti eretti, molto ramificati, i giovani verdi, i vecchi cilindrici e legnosi alla base, che portano foglie alterne di circa tre centimetri a lamina sottile. I piccoli fiori dalle corolle gamosepale bianco-verdicce o rosate, per produrre frutti hanno bisogno degli insetti impollinatori. Il frutto è una pseudobacca carnosa di 4-8 mm, subsferica, blu-violacea o nerastra, pruinosa, appena schiacciata all’apice, dove conserva una caratteristica cicatrice anulare; contiene numerosi semi dalla caratteristica forma a semiluna. Il sapore, com’è noto, è acidulo e molto gradevole. Per questo i mirtilli vengono anche coltivati. La raccolta dei frutti selvatici è regolamentata nelle varie regioni e viene effettuata da raccoglitori autorizzati che utilizzano il “pettine”, una sorta di piccolo cassetto, munito di lunghi denti metallici che staccano i frutticini dai ramoscelli.
Troviamo generalmente le piante di Mirtillo dai 1200 ai 2000 metri in boschi (in prevalenza di abete rosso), in brughiere, cespuglieti, pascoli subalpini, ma sempre su terreni umidi acidofili. È una specie gregaria che tende a formare estesi popolamenti.
Questa pianta, decisamente nordica, era già ben apprezzata dagli uomini preistorici, visto che tra i resti palafitticoli del Trentino sono stati trovati numerosi semi di mirtillo nero.

Il Lampone (Rubus idaeus) e il Rovo (Rubus ulmifolius), invece, sono entrambe Rosaceae.
Il primo è un arbusto con rizoma strisciante da cui partono fusti alti fino a 2 metri, generalmente glabri ed erbacei, che muoiono il secondo anno dopo la fruttificazione. Il secondo è una pianta arbustiva perenne, sempreverde, con rami lunghi, flessibili, spesso striscianti, rampicanti o ricadenti, con radici legnose che generano lunghi polloni ricadenti con gemma apicale radicante.
Questo significa che le “politiche di espansione” delle due specie sono diverse: i Lamponi procedono utilizzando le radici che corrono nel terreno, mentre i Rovi allungano i loro rami che radicano là dove trovano spazio.

I frutti sono simili: entrambi formati da piccole drupe (drupeole); più piccole e in numero maggiore quelle del rovo. Entrambi i frutti sono inizialmente verdi; i Lamponi diventano poi rossi, i frutti del Rovo prima rossi e poi neri e, guarda caso, prendono il nome di More!
Come dicevo, però, mentre troviamo i Lamponi solo oltre i 200 metri d’altezza su terreni freschi e ben drenati, visto che sopportano bene il freddo ma soffrono il clima caldo e secco, i Rovi con le loro dolci more sono ovunque!
È d’agosto che si cominciano a raccogliere, soprattutto nelle aree del Mediterraneo meridionale, i frutti del Mandorlo (Prunus amygdalus),ma di questa bellissima e generosissima pianta potete trovare tutte le notizie nel bellissimo articolo di Beatrice Lupi https://www.earthgardeners.it/2021/02/03/allimprovviso-il-mandorlo/ al quale non ho nulla da aggiungere!

Vi parlo, invece, di altre due specie che producono frutti decisamente poco appetibili per la nostra specie!
La Frangola (Frangula alnus) della famiglia delle Rhamnaceae, produce frutti che non vengono mangiati da esseri umani o animali a causa della loro tossicità. Questa pianta è un arbusto alto da 1 a 4 metri, eretto, con radici affastellate e chioma solitamente non molto densa. Ha foglie di colore verde intenso, lucido superiormente e fiori molto piccoli a 5 petali, a stella, di colore verde biancastro situati in cime ascellari. Il frutto è una drupa subsferica di 6-8 mm, dapprima verde, poi rossa e infine nero-violacea a maturità, con 2-3 semi lenticolari del diametro di 5 mm, di colore bruno-pallido.

È una pianta piuttosto diffusa, abbastanza indifferente alla natura del terreno che si adatta sia a suoli umidi, sia a suoli piuttosto aridi e talvolta pietrosi, sempre però carenti di azoto; vegeta dalla pianura fino a 1300 metri di altezza. Si può considerare specie pioniera, preparatoria all’avvento della vegetazione arborea in situazioni di eccesso di umidità. Alcuni studiosi, per converso, la considerano pianta competitrice, che impedisce per concorrenza spaziale, in certe stazioni, l’insediamento di specie arboree forestali.
Ricordiamo infine l’albero che nel giallo di Agatha Christie “Una tasca piena di segale” fu causa di morte di Rex Fortescue, avvelenato con la tassina, un veleno estratto dal Tasso (Taxus baccata), appartenente alla famiglia delle Taxaceae.
Il Tasso è un albero sempreverde, dioico, ha cioè i fiori maschili e femminili su piante diverse. Può raggiungere i 25 metri di altezza e i 2000 e più anni La sua lenta crescita gli permette di avere un legno molto resistente e duro anche se flessibile, tanto da essere utilizzato, in passato, per fabbricare archi e frecce, cosa che, purtroppo, ha causato un taglio indiscriminato di queste piante che hanno rischiato di sparire da alcune aree d’Europa.

La sua chioma, composta da foglie persistenti e aghiformi, è tendenzialmente piramidale e particolarmente espansa, di colore verde cupo con rami divaricati in orizzontale e ramuli penduli all’estremità. L’aspetto particolarmente gradevole ne fa una pianta utilizzata a scopo ornamentale, tanto da essere presente in tutto il territorio italiano ma non comune allo stato spontaneo. I popolamenti italiani più notevoli sono quelli della foresta Umbra nel Gargano.
Come per le altre conifere di questo stesso ordine l’impollinazione è affidata al vento. I fiori maschili sono riuniti in amenti globosi gialli contenenti 4-8 sacche polliniche; i fiori femminili sono solitari o appaiati, verdi, disposti all’apice di un rametto e contenenti un unico ovulo, che origina un frutto simile ad una bacca (arillocarpo) formata da una caratteristica coppa carnosa (arillo), prima verde, rosso viva a maturità e che copre parzialmente un grosso seme (6-7 mm) nero ovoide, appuntito e legnoso. L’arillo è l’unica parte non velenosa della pianta. Molto appetito dagli uccelli, che riescono a mangiarlo evitando il seme velenosissimo come il resto della pianta.
Consiglio a chi desidera godere della vista di questa splendida specie di cercarla nei boschi ombrosi con suoli calcarei, oltre i 300 metri di quota. La troverà mescolata al faggio, all’agrifoglio e agli aceri.
Crediti
Autore: Anna Lacci è divulgatrice scientifica ed esperta di educazione all’ambiente e alla sostenibilità e di didattica del territorio. E’ autrice di documentari e volumi naturalistici, di quaderni e sussidi di didattica interdisciplinare, di materiali divulgativi multimediali.